No! Fermi! Non sto dicendo che dovete precipitarvi all’apposito ufficio della vostra azienda sanitaria locale per cambiare il nome del medico al quale vi siete rivolti per anni. Sto dicendo che la figura professionale del medico, di quella che bisogna formare nelle università, deve mutare, deve adeguarsi ad una situazione diversa da quella del passato, a un bisogno di salute nuovo, addirittura a un paziente diverso.
Per prima cosa vorrei porre la vostra attenzione sul significato della parola “paziente”. Si pensa, ovviamente, che l’etimologia porti al concetto di pazienza. Invece, sia nelle radici greche (“pathos”) che quelle latine, il termine porta dentro di sé il significato di sofferenza, quello di “sopportare la sofferenza”…solo di sofferenza, insomma, si tratta. Il paziente, quindi, ha dei diritti, prima ancora della malattia che porta con sé. Non bisogna, quindi, meccanicamente applicarsi solo alla patologia, ma al paziente portatore di quella patologia, Sembra banale, ma credo sia una cosa estremamente difficile.
Serve una figura diversa, dicevo: un medico preparato (che conosce, quindi, tutto ciò che è necessario al suo mestiere da “medico chirurgo”) certo, ma che sia orientato alla medicina generale (che caratterizza la figura di un medico formato appositamente dopo il conseguimento della laurea), che abbia conoscenze ulteriori tali da essere in grado di impiegare strumentazione moderna, di interagire con i colleghi, col paziente e con i suoi familiari, di aggiornarsi continuamente in totale autonomia ed altro ancora.

Il corso di studi in medicina e chirurgia, infatti, prepara medici generici, non necessariamente proiettati alla specializzazione e all’ambiente ospedaliero oppure, in qualche caso, a quello della ricerca medica. Questo deve essere chiaro. In molti casi, purtroppo, la formazione accademica è ancora centrata su una medicina clinica che trasmette allo studente solo l’aspetto biologico della malattia, senza insegnare un approccio psico-sociale ai problemi e ai disagi esistenziali dell’uomo, del “paziente” appunto, che determinano la sua vita nel contesto in cui vive e lavora.
E’ al medico di medicina generale che spetta il compito di seguire il paziente, di prendere in carico la sua vita dal punto di vista sanitario (azioni di prevenzione, identificazione primaria dei disagi, capacità di ascolto, diagnosi preliminare in base ai sintomi, informazione, avviamento a ulteriori esami diagnostici oppure agli specialisti del settore ma anche il supporto e il monitoraggio delle patologie semplici, per le quali non è necessario rivolgersi alle strutture sanitarie).
Come si può realizzare tutto ciò? E’ semplice, basta iniziare dal principio.
Per prima cosa bisogna rivedere i corsi di studio; oltre alle discipline scientifiche di ambito medico-sanitario (che, in verità, sono stabilite per legge dal decreto DM 16 marzo 2007 in maniera netta e definita, com’è ovvio che sia per evitare insegnamenti “fantasiosi”) occorre integrare conoscenze, abilità e competenze provenienti da altri settori scientifico disciplinari (detti s.s.d. nel gergo universitario) sia nelle discipline di “base” (fisica, biochimica, informatica, lingua straniera, statistica, solo per citarne i principali e più noti) che in quelle cosiddetta “caratterizzanti” legate, cioè, a ciò che contraddistingue il medico dalle altre figure professionali in ambito sanitario.
Ci si potrebbe domandare cosa c’entri la statistica, ad esempio. Siete veramente certi di aver capito, in questi mesi, tutto ciò che vi veniva descritto sull’evoluzione della pandemia, il coefficiente Rt, il plateau, il massimo della curva…? Concetti che stanno alla base della comprensione dei fenomeni epidemiologici, a prima vista semplici, ma che sottendono la conoscenza di alcune regole impiegate per l’analisi dei dati (cosa sono i dati ? quali sono? quando sono stati presi? a cosa si riferiscono? e quali sono gli errori sistematici, le incertezze casuali, i limiti nel riportarli?), nella loro rappresentazione (grafico, istogrammi, curve di tendenza, etc.) e, quindi, nei modelli, necessariamente statistico-matematici, impiegati non tanto per rappresentare il problema in sé ma per predirne l’andamento, per determinarne la tendenza.
E l’inglese, ad esempio, a cosa serve? Beh, la capacità di chiunque di tenersi aggiornati, leggendo e comprendendo articoli (ma anche video seminari in rete) in lingua straniera è fondamentale. La pandemia ci ha fatto capire che occorre valicare i confini della nostra lingua madre per “capire” cosa sta succedendo nel mondo. Credo che un’ottima conoscenza dell’inglese scientifico rappresenti un valore aggiunto necessario alla propria formazione e all’aggiornamento continuo delle proprie capacità di svolgere bene il proprio compito. La grandissima quantità di cose autorevoli che si possono trovare in rete, immesse pubblicamente da numerose università straniere o sulle principali riviste scientifiche del settore medico-sanitario, è stupefacente, qualunque sia l’argomento trattato. Ciò contribuisce anche in maniera molto significativa, alla possibilità – attraverso il continuous learning, di operare una continua e quanto mai necessaria ricostruzione delle proprie competenze professionali, in funzione dei nuovi bisogni di salute imposti dai cambiamenti scientifici, tecnologici, demografici e socio-economici del territorio dove si opera.
Inutile dire che una familiarità delle tecniche digitali aiuta da un lato a gestire flussi di informazione e dall’altro a scambiarli rapidamente. Oggi tutto è digitale, dalle ricette ai risultati di alcune analisi; ad esempio, l’uso di un sistema di visualizzazione di una radiografia digitale, o di una TAC è fondamentale per capire eventuali problemi ma occorre conoscerne anche i limiti, ovviamente, altrimenti qualunque “opacità” potrebbe mettere ingiustificatamente in allarme.
Il digitale rientra anche nel funzionamento di molti strumenti di diagnosi e/o monitoraggio continuo. E’ necessario conoscere questi strumenti, saperli impiegare ed essere pronti ad usarli ogni qual volta necessario, per monitorare lo stato di salute di un anziano, per tracciarne l’evoluzione anche quando si trova delocalizzato (nei centri rurali, ad esempio) evitandogli di spostarsi negli ambulatori o, addirittura, negli ospedali a meno che non sia strettamente necessario. La telemedicina è l’unico modo per rendere più efficace, non solo efficiente, questa azione, alleggerendo l’afflusso ospedaliero.
Il medico moderno deve anche saper interagire con gli altri. E’ importante che il medico sia al centro di una rete di colleghi, anche specialisti, in modo da gestire le patologie direttamente senza dirottare il paziente, costringendolo a inutili peripezie. Anche in questo caso, lo scambio di analisi e referti così come il consulto, svolti telematicamente, agevolerebbe, rendendolo più rapido ed efficace, la diagnosi e i conseguenti provvedimenti. Il paziente, in tal caso, non dovrebbe più andare avanti e indietro a inseguire medico da un lato all’altro della città o della provincia. Attendiamo da anni, ad esempio, la diffusione completa del “fascicolo elettronico” anche per questo.
Il medico moderno deve, inoltre, integrarsi in quella che viene definita medicina di prossimità, capace di rappresentare uno dei nodi di una rete di specialisti ambulatoriali, medici di famiglia e pediatri per garantire ai cittadini un’efficiente assistenza sanitaria sul territorio ed evitare il ricorso, talvolta non necessario, alle strutture ospedaliere, con un possibile snellimento delle liste d’attesa. Se avessimo avuto, perfettamente funzionante, una struttura del genere, avremmo sicuramente avuto una capacità di reazione all’emergenza pandemica di gran lunga più efficace e veloce.
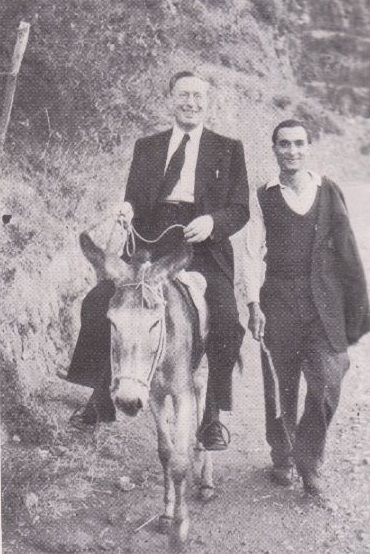
Il medico deve saper interagire con il paziente (magari avendolo innanzi a sé e non al telefono), deve saperne ascoltare i sintomi e interpretarne i segni, certo, ma anche avere la capacità (che si assume con lo studio di discipline psicologiche e sociali) di entrare in relazione con lui, di comprenderne il disagio, a volte i problemi in ambito familiare. Deve, inoltre, sapersi relazionare anche ai parenti, comprendendo il peso che talvolta ha la patologia in ambito familiare ed extra-familiare.
Quanto mi piacerebbe che, nell’informare il paziente del tempo da attendere per il risultato di un analisi che lo preoccupa, al posto di “cosa vuole, sono i tempi necessari, due/sette/quindici giorni” si possa ascoltare un “la capisco, saranno giorni difficili, stia tranquillo e se ha bisogno di me, mi chiami senza indugio”…
Un altro dei problemi (in realtà abbastanza antico) è quello della progressiva “terzillizzazione” del medico di famiglia (ricordate il grandissimo Alberto Sordi nella sua interpretazione del Dott. Guido Terzilli), costretto a seguire un numero elevato di pazienti con il risultato che, il paziente stesso non lo frequenta. Il paziente è cambiato, infatti: la sua (in)competenza, oltre ad esercitarsi nel campo calcistico, politico e –ultimamente- virologico-, con l’aiuto dei motori di ricerca si è espansa in campo medico-sanitario al punto di “diagnosticarsi” e, peggio,” curarsi da solo” non sentendo più il bisogno di consultarsi con il “collega” medico di medicina generale. Ogni volta che penso a questa cosa mi viene in mente quello splendido passo di “Tre uomini in barca” di J.K. Jerome, quando il protagonista, recatosi nella biblioteca del museo per consultare un libro sulle malattie, lo sfoglia tutto e scopre che la sola malattia che non sentiva di aver avuto era il ginocchio della lavandaia.
Sempre più spesso (sarà perché frequento farmacie molto accoglienti, e in questo sono fortunato) assisto a scene nelle quali il paziente (o, talvolta, presunto tale) si affida a un farmacista gentile, educato, esperto, preparato (per passione ben al di là degli studi che ha fatto, per nostra fortuna), come se fosse la propria madre. Confida a lui i propri problemi, aspetta i suggerimenti e verifica, costantemente, se il medico (quando interpellato) gli abbia detto la verità. Anche il profilo del farmacista dovrebbe mutare. Penso alla farmacia moderna come a un pub inglese, nel quale non si va solo a “consumare” una bibita … ma questa è un’altra storia…
Riusciremo a dare una risposta a queste esigenze di cambiamento? Secondo me, si! siamo sulla buona strada ma … questa è un’altra storia.
]]>