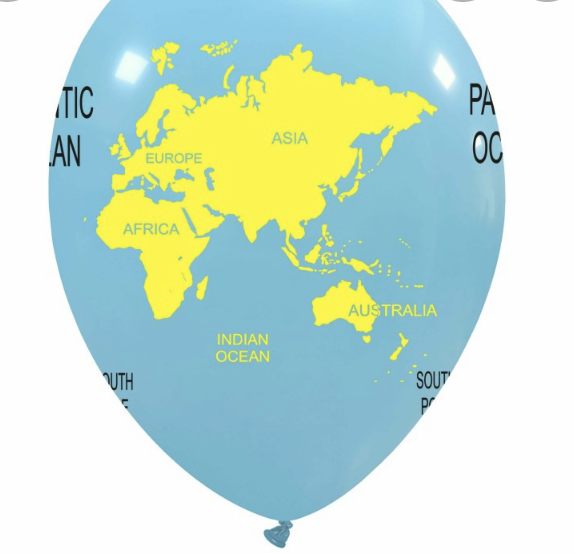C’è chi crede nello spirito che si realizza nella Storia e chi no. Io no. E dunque penso che le cose che sono accadute in una qualche maniera sarebbero potute divergere lungo altre biforcazioni, e che spesso la chiave che apre il passaggio dall’una o dall’altra parte ha la fragilità di un battito d’ali di farfalla.
Ciò premesso, immagino di tornare al 1 luglio del 1991, l’anno in cui, come aveva predetto Francis Fukuyama, con lo scioglimento ufficiale del Patto di Varsavia, sarebbe potuta finire la storia, se con tale nome, come siamo abituati (al punto da non riuscire a immaginare qualcosa di diveso) intendiamo una cronologia di guerre, patimenti e rivoluzioni sanguinose. Sono nel 1991, dunque, il muro di Berlino è stato abbattuto da due anni e Michail Gorbačëv si comporta come mai si era comportato chi aveva avuto fra le mani le redini di uno stato forte e orgoglioso qual era (ed è) la Russia. Egli, inizialmente intenzionato a una fusione euroasiatica, aveva finito per l’aggettare la riunificazione della Germania all’interno dell’Alleanza Atlantica. Queste, le testuali parole della promessa (verbale) che gli fu fatta: «Non solo per l’Unione Sovietica, ma anche per altri Stati europei è importante la certezza che, se gli Stati Uniti manterranno la propria presenza in Germania sotto l’egida della NATO, questa non estenderà la propria giurisdizione verso est neppure di un centimetro». Immagino, molto sinteticamente, ciò che sarebbe potuto accadere se la parola fosse stata mantenuta: una Russia che si avvia lungo un percorso di democratizzazione, e che dopo dieci anni è già avanti al punto da rendere inverosimile che un uomo ambizioso e spregiudicato del KGB possa prendere il potere. A Gorbačëv fanno seguito politici animati dai suoi stessi ideali, cosicché, piano piano, anche la NATO smarrisce la sua ragione d’esistenza e si disgrega, lasciando aperto uno spazio d’alleanza, basato su interessi comuni di catattere economico-sociali, dalle sponde orientali dell’Atlantico agli Urali, che prenderà il nome di Eursia. L’America e l’Eursia vivranno a lungo ognuna con le proprie risorse di energia, riuscendo, con il loro esempio, a cambiare le sorti di larghe zone dell’Africa e del Medioriente e finanche della Cina.
Non è andata così. Ciò che è accaduto è ben noto. La Nato (leggi “America”), dopo quella promessa-farsa ha iniziato a espandersi arrivando fino ai confini con la Russia e ha leso più volte la sovranità nazionale degli Stati dicendo di essere interessata ad “esportare la democrazia”, ma in realtà interessata ad accaparrarsi il controllo dell’energia.
Scrivo questo perché è necessario ricordarlo e dirlo, quantomeno per poter capire le ragioni di chi, dinanzi al macello in atto in Ucraina, si oppone alla visione in bianco e nero, e magari – ingiustamente – viene additato come insensibile se non proprio traditore (ricordiamolo: c’è anche una dittatura della sensibilità cieca e bieca).
Il problema, in effetti, non è se Putin sia o non sia un fanatico reazionario e rancoroso: è la stessa condizione in cui versa il popolo russo a rivelarlo (mentre, solo pochi mesi fa tanti, anche qui da noi, lo ammiravano), non c’era bisogno della guerra perché la verità venisse a galla. La questione, semmai, è un’altra: Putin si sarebbe potuto evitare se gli accordi fossero stati rispettati?
Certo, non si può più tornare indietro e sognare, utopicamente, una fantomatica Eursia che poteva esserci e non c’è stata. E Putin è molto, molto peggio della NATO. Ma si può provare ad andare avanti con consapevolezza, ovvero accettando la ricchezza delle sfumature e tenendo a mente che non è lo spirito della Storia a manipolare gli uomini per portare a termine il suo itinerario dialettico, ma, viceversa, è la potenza immaginativa delle menti e la loro determinazione a dare forma al mondo.