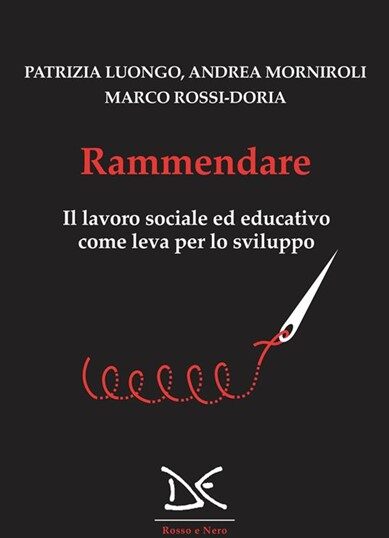Non amo presentare libri, un po’ perché ne ho, forse, presentati tanti, troppi, ma soprattutto perché sei costretto a leggerli in maniera sbagliata, li leggi senza abbondono, pensando a ciò che devi dire. Precisiamo: non amo presentare libri che leggi perché li devi presentare. Poi se è presente l’autore in “campagna promozionale”, non ne parliamo, spesso fenomeni, tronfi, che per lo più prenderesti a calci in culo, mi è capitato e mi sono dovuto trattenere recitando a mente “T’amo Pio Bove” di Carducci.
Mi piace piuttosto parlare dei libri che ho letto e che mi hanno colpito e perciò ho voglia di proporre agli altri. Naturalmente ci sono le eccezioni, a volte ti propongono di leggere un libro da presentare che avresti avuto difficoltà a intercettare, che ti colpisce profondamente e i cui autori sono normali “autori” che raccontano “cose” utili. E’ questo il caso di “Rammendare “ di Patrizia Luongo, Andrea Moniroli, Marco Rossi Doria, Donzelli Editore. E sei talmente colpito da decidere di scriverne una riflessione per i tuoi amici immaginari on line.
Parto da una considerazione, che mi accompagna molto ultimamente: come mai nel dibattito culturale dell’ultimo ventennio è scomparsa completamente la riflessione di natura pedagogica? Lo dico con nostalgia avendo vissuto , scritto e partecipato negli anni settanta e ottanta e in parte novanta, ad una stagione dove la pedagogia era una sorta di bussola politica oltre che culturale. I pedagogisti quasi dei “maitre a penser” anche politici. Penso a Frabboni, Pinto Minerva, La Porta, Laeng, De Bartolomeis, Makarenko, Gardner, Bruner, Ponce, Illich, Rogers e naturalmente don Lorenzo Milani che per me ha contato quanto il barbuto di Treviri. Non a caso mi sono laureato in Pedagogia prima di una triennale specialistica in Filosofia, ho lavorato e scritto molto in quegli anni sulle connessioni tra queste due discipline, pubblicato ricerche, fatto il maestro elementare per un decennio nelle scuole sperimentali, per un altro decennio il ricercatore e il formatore all’ IRRE (Istituto Regionale Ricerca Educativa).La pedagogia si sposava e dava forza all’interesse per la politica, al mio impegno, alla mia militanza, ero fortunato e felice facevo un lavoro che incrociava i miei interessi più profondi.
Si, va bene, ma il libro? Il libro è tutto questo, il sottotitolo lo esplicita: “il lavoro sociale ed educativo come leva per lo sviluppo”, e ho detto tutto…direbbe “qualcuno”. Non è un libro “teorico” o meglio è un libro dove la teoria c’è e si sposa con la pratica, la ricavi dai fatti, dalle pratiche di “militanza sociale”, dal dover dare delle risposte immediate, dal racconto di come si costruisce una “coscienza”, di come sia difficile oggi fare lavoro sociale, “anche perché all’aumento di povertà e nuove fragilità non è corrisposto un aumento degli investimenti e un rafforzamento delle politiche pubbliche in materia di welfare. Al contrario, abbiamo assistito a un feroce, progressivo e costante processo di sottrazione di risorse e attenzione pubblica in tale ambito.”
Spesso mi è capitato, leggendolo, di rammentare (è un rammendare la propria vita pure quello) il mio primo anno di insegnamento, avevo poco più di vent’anni, mi ero appena laureato (si ero precoce) sbattuto da Roma in una campagna di Potenza ad insegnare in una pluriclasse di scuola elementare. Tutto quello che so, quello importante, l’ho appreso lì, poi quando sono passato ai licei ad insegnare la mia amata Filosofia, mi divertivo, mi sembrava quasi di rubare lo stipendio, di fare un lavoro che avrei fatto anche gratis.
E prima ma subito dopo le pluriclassi , la grande esperienza del tempo pieno “ sperimentale”, una esperienza andata poi più tardi a “regime” partita dal quartiere operaio delle “Vallette” a Torino, l’abolizione dei voti, l’integrazione in classi normali dei bambini fino ad allora destinati alle classi differenziali, una grande dirigente scolastica, socialista, colta, battagliera (Maria Schettini) che contro i pregiudizi ed il potere politico permetteva tutto questo nella scuola a tempo pieno “Domiziano Viola” di Potenza, proteggeva un gruppo di giovani, tutti laureati, che sperimentavano i metodi di Carl Rogers, se ne fottevano dei programmi , abolivano i voti, facevano gli esami collettivi alla fine della quinta classe, in una scuola di un quartiere tutt’altro che borghese, dove qualche bambino, ancora non arrivava alla licenza, perché moriva di “epatite”, dove per il saggio di fine anno si rappresentava Rodari, Lodi e il venerdi si leggeva “Il Maestro e Margherita” di Bulgakov, un russo pensa un po’, e si cantava “el pueblo unido jamás será vencido”.
Il problema non è di riportare dalla strada i ragazzi in classe ma al contrario riportare la scuola in strada. Strana “transumanza” che percorre il libro e percorreva quegli anni: contro l’abbandono spostare la scuola non solo fisicamente (cosa complicata) ma nei contenuti.
Tommaso Campanella nella sua splendida utopia , La città del Sole, scrive un libro che è anche , solo a saperlo leggere, un manifesto politico, per edificare un mondo nuovo parte proprio dall’educazione, come del resto Platone nella Repubblica. I bambini guidati , da antenati di quelli che oggi si chiamerebbero maestri di strada, apprendono andando in giro per le strade della città sui cui muri sono riportati, come sui libri, tutte le conoscenze possibili, si affacciano i luoghi del sapere e del fare, dove non c’è scissione tra sapere e vivere concretamente, dove non apprendono solo gli alunni ma anche i maestri. Carl Rogers non ha inventato nulla, e dal fondo dei ricordi ritorna un libro di Karoll sulla rivoluzione cubana e sulla campagna di alfabetizzazione che permetterà a Cuba di diventare il paese più alfabetizzato dell’America Latina in pochi anni.
Ma oggi c’è internet, Wikipedia, si può leggere tutto sul proprio PC, si può accedere pressoché a tutte le informazioni, ma non basta leggere bisogna pure capire, avere capacità di attenzione, indugiare sulle parole, sentire il calore delle persone, la comprensione è un processo individuale ma anche sociale. Anzi più sono le informazioni disponibili maggiore deve esser la capacità critica di “scegliere”.
Ma il libro? E già il libro, se volete sapere di che parla leggetelo, i libri si devono leggere di questo posso solo dire che riattiva la passione civile, i ricordi di quando eravamo migliori , la voglia di ritornare ad esserlo.
Ma la crisi, il covid, la guerra……? Già….appunto….Ripeto meglio leggerlo, insisto: i libri si devono leggere proprio, non esistono scorciatoie. Non siete abituati ? Abituatevi e spegnete sti cazzo di telefonini, smettete di fare i colti col copia e incolla e le citazioni di autori che manco sapete chi sono tanto non rimorchiate neanche.